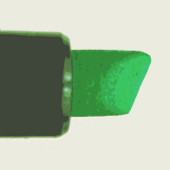Estate: la preparazione
3. Faccio un passo indietro per spiegare un passo avanti
Tre anni dopo quella rinuncia, però, fui costretto a ritornare sull’argomento. Era nuovamente estate – l’estate del 1999 – ed Emanuela Franti sarebbe andata in quinta, riscattando finalmente la fama del suo pessimo avo, anche senza i miei insegnamenti sul modo migliore per stendere una relazione di laboratorio. Qualche mese prima, tuttavia, era stata approvata una di quelle leggi secondarie che non raggiungono mai la prima pagina dei quotidiani (per la verità neppure la seconda, la terza…) ma che movimentano le colonne dei bollettini sindacali con trafiletti raggianti o velenosi. Sto parlando della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e precisamente l'articolo 5, comma 1, lettera a che ha cambiato la mia vita di insegnante.
Ora, può sembrare un po’ esagerato dire che quella innocente lettera a ha cambiato la mia vita, seppure sotto il profilo professionale, ma questa è la semplice verità. Sono andato a controllare il mio stato di servizio – una cosa che si fa normalmente quando si comincia a pensare che forse è arrivato il momento di andare in pensione – e ho calcolato che nell’estate del 1999 la mia anzianità di servizio aveva raggiunto il ragguardevole ammontare di 28 anni. Che cosa poteva mai aver sconvolto, dunque, quel consolidato bagaglio di anzianità e di esperienza, per indurmi a riconsiderare praticamente da zero, in quell’estate del 1999, tutta la mia carriera di insegnante?
Per comprendere quello che mi era successo, come si usa in tutte le storie che si rispettino, bisogna fare un passo indietro. Se esamino più attentamente il mio stato di servizio, infatti, mi accorgo che nei primi sei anni di carriera ho fatto l’insegnante di doposcuola nella scuola media. Veramente, sullo stato di servizio non c’è scritto doposcuola, bensì libere attività complementari, ma anche volendo apprezzare la fantasia mostrata dai burocrati del Ministero della pubblica istruzione nel designare la mia speciale funzione, resta il fatto che io prendevo in consegna gli studenti nel pomeriggio, dopo che i colleghi di italiano e di matematica li avevano spremuti a dovere la mattina, e cercavo di spiegare loro che la scuola non era solo un luogo di tormento – come essi fermamente ritenevano – ma possedeva anche un aspetto ludico, come piaceva dire allora, e io ero pagato appositamente per rivelarglielo.
Rivelai loro, dunque, le difficoltà e i piaceri del ferromodellismo, della fotografia, della falegnameria e di svariate altre attività manuali. Insieme con un altro insegnante di doposcuola, per esempio, un anno realizzai un plastico ferroviario di quasi sette metri quadrati di superficie; qualche anno dopo sequestrai un bagno della scuola per adibirlo a camera oscura; sempre con l’aiuto di altri insegnanti di doposcuola, sempre in quegli anni, trasformai un grande locale vuoto in qualcosa che voleva assomigliare a un cinema-teatro: fu costruita una cabina di proiezione cinematografica e un palcoscenico di oltre trenta metri quadrati di superficie, con tanto di quinte.
Il mio impegno era notevole e gli studenti dimostravano di apprezzare e di assecondare tutte le mie iniziative nel modo che veniva loro più spontaneo, ovvero producendo un intenso rumore da un lato e molta allegra confusione dall’altro. I colleghi di italiano e di matematica, dal canto loro, approvavano benevolmente i miei sforzi ma era evidente che, al momento di tirare le somme, quello che contava era il profitto in italiano e in matematica; a me toccava farmi da parte, e non dico che in fondo non fosse giusto così.
Per i primi sei anni della mia carriera, insomma, sono stato un professore dimezzato, il che, a guardare bene le cose, non è stato neppure un fatto troppo negativo. Quando uno insegna – in senso lato, s’intende – una materia come ferromodellismo, e capita che gli studenti non lo stiano a sentire, non può mica alzare la voce minacciando:
– Se non mi ascoltate vi metto quattro a tutti.
Infatti, se una cosa del genere la diceva il collega di matematica si trattava di una ponderabile minaccia, ma se la dicevo io era solo umorismo involontario. E gli studenti, come è noto, magari zoppicano in inglese, ma quanto a sense of humour hanno quasi tutti la sufficienza abbondante.
Dunque, per un docente delle libere attività complementari, che i colleghi di italiano e di matematica potevano chiamare animatori – neanche fossero dipendenti di un villaggio turistico, assunti dal Ministero per mostrare il volto amabile dell’istituzione scolastica – l’unico modo per farsi ascoltare dagli studenti era conquistarli. Ho dovuto escogitare svariate tecniche di cattura dell’attenzione e della benevolenza studentesca perché non potevo fare il minimo conto sul Registro del Professore, ovvero il simbolo, la memoria e la difesa di quel modesto potere che l’istituzione metteva in mano al docente – ma non all’animatore – per l’esercizio della propria funzione. È stato piuttosto duro.
Ho imparato ad essere un bersaglio mobile. Essi – gli studenti – all’inizio vibravano delle terribili stoccate di baccano e di indifferenza e io cercavo di evitarle saltellando metaforicamente di qua e di là per non essere sopraffatto dai loro fendenti, oltre che dallo sconforto; poi, mentre essi sostavano un istante, preparandosi a menare il colpo successivo, approfittavo della breve tregua e li toccavo rapidamente con una trovata inattesa che li lasciava di stucco: qualsiasi cosa andava bene, bastava che non se la aspettassero, bastava che rimanessero disorientati, sorpresi, basiti. E quando la breccia fra le piastre della loro corazza di superficialità era aperta: ecco, il gioco era fatto!
Magari. Quando la breccia era aperta bisognava allargarla, e questa era la fase più lunga e più difficile del lavoro, un quotidiano corpo a corpo. Però ci si può riuscire, anche se non hai quella durindana che è il Registro del Professore. Anzi, se non ce l’hai, in un certo senso è meglio, perché acquisisci ed affini un modo per entrare in rapporto con gli studenti che è più limpido, dal momento che non è viziato dal possesso di un oggetto sostanzialmente estraneo al rapporto di stima e di fiducia che rende solido e duraturo il dialogo fra le parti.
Insomma, per i primi sei anni della mia carriera sono stato un professore senza registro che insegnava discipline assolutamente marginali; però non credo di essermela cavata tanto male, senza contare il fatto che ho imparato un mucchio di cose che, prima o poi, mi sarebbero servite. D’altra parte, si sa, gli inizi sono spesso incerti e difficili.
Superati gli inizi, tuttavia, e venendo alla maturità professionale, dico subito con semplicità che le cose sono rimaste sostanzialmente immutate per lunghi anni, anche se vi furono cambiamenti sensibili. A partire dal 1977, infatti, chiusi con le attività ludiche nella scuola media e mi applicai nientedimeno che alla fisica, quella che si praticava nei laboratori omonimi degli istituti tecnici industriali.
Non ho alcuna soggezione nel proclamare che la mia carriera di insegnante di attività altamente futili è stata fulgida e molto appagante, anche se ricordo con un certo imbarazzo, per essere sincero, quella volta che mi sono fatto fotografare dagli studenti steso su un banco con una patata in bocca, mentre mi sforzavo di somigliare il più possibile a un arrosto. Stavamo realizzando insieme una sequenza fotografica per un audiovisivo a metà strada fra il surreale e il demenziale che ci procurò grande divertimento durante la realizzazione e numerose lodi quando lo sottoposi al giudizio dei miei colleghi.
Ma con la fisica fu subito tutto diverso. Se devo essere sincero non posso dire che mi ero stufato di fare l’arrosto; il fatto è che si erano stufati quelli del Ministero di lasciarmelo fare, perché vennero chiuse tutte le scuole medie sperimentali che costituivano la nicchia ecologica dove poteva sopravvivere quella curiosa specie di insegnanti che erano gli animatori; di conseguenza, tutti i docenti delle libere attività complementari vennero messi in libertà.
Studente universitario in ritardo sui corsi, ma già felicemente coniugato, mi aggrappai all’unica ancora di salvezza economica che il mio braccio poteva raggiungere con il titolo di studio che possedevo quando mi ritrovai per strada: fui pertanto, e per la prima volta nella mia vita, insegnante tecnico-pratico di laboratorio di fisica presso ben due istituti tecnici siti nel più lontano luogo dove si estendeva la giurisdizione del Provveditorato agli studi competente per la mia provincia.
Ripensando oggi a quella vicenda, a distanza di tanti anni, mi rendo conto con un po’ di sorpresa che non mi passò neppure per la testa l’idea di cambiare mestiere, eppure il mutamento fu enorme e quindi il pensiero tutt’altro che irragionevole. La scuola dove animavo gli studenti era proprio sotto casa, mentre per raggiungere le due nuove sedi di lavoro dovevo attraversare mezza pianura padana. E poi, si poteva dire che andavo ad insegnare il laboratorio di fisica? Io studiavo lettere, e casomai potevo ambire ad insegnare, prima o poi, la lingua e la letteratura, perciò in quell’autunno del 1977 avrei preferito dire che andavo ad imparare la fisica e il relativo laboratorio, visto che di quanto sapevo per decreto ministeriale di questa disciplina ricordavo ormai ben poco. Ma insegnare, probabilmente, mi piaceva più di quanto immaginassi.
Fare l’insegnante tecnico-pratico non era affatto una attività appagante in quegli anni, tuttavia c’erano diverse circostanze che rendevano il lavoro ancora più mortificante:
1. farlo da supplente;
2. farlo molto lontano da casa;
3. farlo in due scuole distinte; e soprattutto
4. farlo a 25 anni.
Non più animatore di libere attività, adesso ero diventato assistente di laboratorio, termine non contemplato dal lessico ministeriale, ma usato assai comunemente nei commerci verbali quotidiani fra i docenti. Ero principalmente l’assistente di laboratorio di un ottimo professore di fisica che mi trattava come uno scudiero, aspettandosi nel contempo che io mi mostrassi tale, ovvero fido e sottomesso. Compresi ben presto che continuavo ad essere un professore dimezzato, come quando insegnavo agli studenti delle medie come si costruisce la galleria in un plastico ferroviario, oppure richiamavo la loro attenzione sul fatto che tagliare un pezzo di legno evitando nel contempo di tagliare anche il dito che lo tiene fermo non è una impresa banale.
Però c’era una differenza. Riflettevo su quell’aggettivo che qualificava il mio passato lavoro: libere attività complementari. Quell’aggettivo voleva dire che, per quanto accessoria e futile fosse la mia attività, per quanto priva di quel baluardo del potere che era il Registro del Professore, io avevo il diritto di esercitarla liberamente, una volta approvata dall’autorità competente. In altre parole, avevo posseduto l’autonomia didattica, ovvero quella preziosa risorsa che, a dispetto di tanti luoghi comuni, rende sempre nuovo e fertile il lavoro di un insegnante, anche del più umile.
Ormai non più. La disciplina si chiamava Fisica e laboratorio, e l’insegnamento veniva impartito da una coppia di docenti che, in gergo, venivano anche designati come il teorico e il pratico. Tuttavia il registro e soprattutto l’autonomia didattica spettavano solo al primo – il cavaliere – mentre al secondo – lo scudiero – spettava solo il diritto di esprimere il proprio punto di vista, che naturalmente poteva essere tranquillamente ignorato.
Mi viene in mente il mitico Ruggiero dell’Orlando furioso di Ariosto, che per poter riavere l’amata Bradamante parte baldanzosamente alla conquista di un regno.
e poi di Mandricardo, si riveste,
e fa la sella al buon Frontino porre,
e cimier muta, scudo e sopraveste.
A questa impresa non gli piacque torre
l’aquila bianca nel color celeste,
ma un candido liocorno, come giglio,
vuol ne lo scudo, e ’l campo abbia vermiglio.
Dopo aver preso queste importanti decisioni, Ruggiero giudica opportuno anche scegliere uno scudiero che sia all’altezza dell’impresa che si appresta a compiere.
e quel vuole e non altri in compagnia.
Ebbene, il mio collega di teoria non potè scegliersi l’assistente di laboratorio per andare all’annuale conquista degli studenti, sfoggiando l’insegna del candido liocorno, ma dovette accontentarsi di uno scudiero iscritto nelle apposite graduatorie ministeriali. Non rinunciò tuttavia ad esercitare in maniera assai esclusiva la propria autonomia didattica dimodoché, se lo scudiero avesse voluto esprime rispettosamente il proprio punto di vista sulle scelte didattiche del collega, forse, Ariosto avrebbe potuto aggiungere al suo bel poema cavalleresco un’ottava di questo tenore:
vogliate perdonar se lo scudiero
ebbe un’idea, magari di buon estro,
e ve la dice piana e per intiero:
parreste in armi forse più maestro
ponendo in capo un altro bel cimiero.
– Grazie, ci penserò senz’alcun fallo.
Torna alla striglia, adesso, del cavallo.
Scoprii, con crescente disagio, che mentre la mancanza del Registro del Professore mi risultava sopportabile, trovavo al contrario intollerabile la mancanza dell’autonomia didattica. Le due mancanze, in fin dei conti, erano le due facce di una stessa medaglia, ma io vivevo la seconda come una vera e propria mutilazione della funzione docente, mentre la prima mi appariva solo come una plausibile limitazione, alla quale avevo imparato ad ovviare fin dai tempi del doposcuola.
Dunque nel 1977 incominciò la mia carriera di scudiero didattico che proseguì tranquillamente per 22 anni. In questo lungo periodo, oltre a studiare la fisica, trovai il tempo per dedicarmi a svariate altre attività, come laurearmi e quindi sbalordire il mio piccolo pubblico quando sfoderavo quel titolo accademico così lontano dalla mia fatica quotidiana, fare due figli, essere bocciato in altrettanti concorsi per una cattedra di natura più pertinente alle mio attuale magistero, pubblicare alcuni libri ed essere apprezzato e remunerato da vari soggetti proprio in quel campo dove invece il Ministero, per mano di alcune commissioni giudicatrici, si era rifiutato ostinatamente di riconoscere la mia attitudine. Come molti altri della mia generazione, io mi ero iscritto alla facoltà di lettere, al tempo, perché nutrivo l’ambizione di cancellare l’onta che la professoressa, svergognata da don Lorenzo Milani e dai ragazzi di Barbiana nella famosa Lettera, aveva gettato sulla scuola media italiana. Mi ritrovavo invece nell’impossibilità di condurre a termine quel disegno, non tanto perché mi ero distolto dalla meta, ma perché il Ministero si era opposto in modo insindacabile.
A distanza di quarant’anni molte delle idee giacobine contenute in quel libro mi appaiono tramontate irrimediabilmente, e considero don Milani un uomo dal credo troppo esaltato, come sanno essere spesso i preti e i motociclisti, però su una cosa aveva visto nel giusto, cioè nell’uso consapevole delle parole come strumento di promozione personale e di crescita sociale. Questo rimane per me un obiettivo didattico fondamentale. Ma allora, invece che ad insegnare italiano ai ragazzi della scuola media, mi ritrovai ad eseguire esperimenti scientifici in un laboratorio di fisica davanti ai giovani dell’istituto tecnico industriale, sotto l’occhiuta tutela del teorico di turno.
Alla fine, poco male. So di ingegneri nucleari che si occupano di ascensori, eppure non spendono tutto quello che guadagnano dall’analista per farsi alleviare le frustrazioni. Dopotutto, lavoravo nella scuola, come avevo desiderato, sebbene il mio profilo professionale fosse piuttosto sfuggente. Pazienza. Il profilo sfuggente, in verità, è sempre stato un tratto caratteristico degli insegnanti di laboratorio: qualcuno ne ho fatto un pretesto per defilarsi con destrezza dalle responsabilità, qualcun altro ne ha fatto un cruccio per lamentarsi in continuazione. La maggior parte, però, se ne è fatta semplicemente una ragione. E io fra quelli.