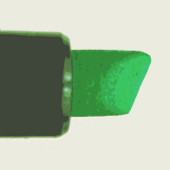Estate: la preparazione
7. Feynman, Galileo, Ariosto
Non ero affatto sicuro, in realtà, che gli studenti del mio istituto morissero dal desiderio di apprendere come si scrive una relazione di laboratorio, però era questo che li aspettava a settembre, e io mi stavo preparando con molto scrupolo all’appuntamento. Mentre lavoravo al mio progetto, durante la lunga pausa estiva, e cercavo di dare sostanza a quel modello mente-carta-mente al quale ho già accennato e sul quale tornerò spesso, mi capitava di riflettere sulle parole che Richard Feynman disse una volta, nel corso di una delle sue famose lectures: “I poeti non scrivono per essere capiti” (poets do not write to be understood).
Feynman era un grande scienziato che amava vestire i panni del rustico yankee impermeabile a certe fumosità della cultura umanistica, ma in questo caso, secondo me, si sbagliava. Galileo Galilei, per esempio, era un grande scienziato, ma era anche un uomo imbevuto di squisito spirito umanistico e proprio nella letteratura poetica del Cinquecento cercava e riconosceva modelli di chiarezza e di efficacia espositiva.
È ben nota, infatti, la sua grande passione per l’Orlando furioso di Ariosto – si dice che lo conoscesse quasi tutto a memoria – e il suo altrettanto grande disprezzo per la Gerusalemme liberata di Tasso. Galileo giustificava una diversità di giudizio sulle due opere così netta con argomenti linguistici (Considerazioni al Tasso, in Le opere di Galileo Galilei, vol. ix, Firenze, Barbèra, 1899, p. 63).
Sfuma e tondeggia l’Ariosto, come quelli che è abbondantissimo di parole, frasi, locuzioni e concetti; rottamente, seccamente e crudamente conduce le sue opere il Tasso, per la povertà di tutti i requisiti al ben oprare.
Sfuma e tondeggia l’Ariosto, e vorrei arditamente aggiungere di mio, in temperate parole le quali, precise e minute, sciamano nel testo, illuminandolo di significato. Altro che scrivere senza farsi capire. L’ottava di Ariosto è una macchina per produrre significato di straordinaria efficacia. Non resisto alla tentazione di citarne una fra le più celebri (Canto xxxix, 54), quella che descrive la cattura di Orlando pazzo da legare il quale, effettivamente, viene legato sotto la regia di Astolfo con una precisa e collaudata tecnica.
e con nodi correnti adattò presto;
et alle gambe et alle braccia alcune
fe’ porre al conte, et a traverso il resto.
Di quelle i capi poi partì in commune,
e li diede a tenere a quello e a questo.
Per quella via che maniscalco atterra
cavallo o bue, fu tratto Orlando in terra.
Questa ottava non è solo un passo della storia, ma sembra anche il frammento di un trattato di arti e mestieri, dove viene spiegato dettagliatamente il modo migliore per catturare in sicurezza un grosso animale. A Galileo l’ottava doveva piacere per la peculiare capacità di questo metro di prestarsi al discorso preciso e concluso, che è proprio del parlare scientifico. Se la rima è una dimostrazione poetica – ovvero un accorgimento per rafforzare l’efficacia retorica del discorso – l’ottava sicuramente è il luogo dove meglio può esercitarsi questa dimostrazione.
All’interno dell’ottava, infatti, vi è un meccanismo concepito espressamente per facilitare l’incisività e la necessità del discorso. I primi sei versi pongono la premessa del ragionamento, la cui coerenza è poeticamente garantita dalle rime alternate che fanno – si può dire – da sponda ai concetti espressi. Gli ultimi due versi, invece, esprimono la conclusione del discorso, che scatta rapida e sicura, suggellata dalla rima baciata che ha il sapore del ben noto come volevasi dimostrare. Questa breve unità verbale, costretta in soli otto endecasillabi, impone allo scrittore il dovere di racchiudere il proprio pensiero entro confini quasi inviolabili, il che implica la necessità di un discorso che sia chiaro e preciso in maniera esemplare.
Insomma, forse Feynman è stato un po’ troppo severo nel giudicare i poeti, ma la verità è che egli non aveva solo diffidenza per le poesie, egli diffidava proprie delle parole. Scrive in uno dei suoi due libri di ricordi (Richard P. Feynman, “Che t’importa di ciò che dice la gente?”, Bologna, Zanichelli, 1989, p. 5-6):
“Lo vedi quell’uccello?” diceva mio padre. “È l’usignolo di Spencer.” (Sapevo che non ne conosceva il nome corretto.) “In italiano si dice, mettiamo, Ciutto Lapittida. In portoghese Bom da Peida. In cinese Chung long tah; in giapponese Katano tekeda. Puoi saperne il nome in tutte le lingue del mondo ma quando l’hai imparato non sai assolutamente niente dell’uccello. Saprai qualcosa degli uomini nei vari posti, e il nome che essi danno all’uccello. Guardiamolo invece, per vedere cosa sta facendo; è questo che conta.” (Apprezzai molto presto la differenza tra conoscere il nome di una cosa, e conoscere una cosa.)
Feynman amava molto il padre, che per primo lo aveva iniziato alla curiosità scientifica, cosa della quale tutti dovremmo essergli grati. Ma purtroppo insegnò al figlio anche il sospetto per le parole, e di questo non mi sembra altrettanto giusto rallegrarsi. Per campare il padre di Feynman vendeva uniformi e disprezzava paradossalmente tutte le differenze fra gli uomini che derivavano dall’abito:
Quand’ero piccolo e mi metteva a sedere sulle ginocchia, mi faceva vedere le pagine del New York Times – erano le prime foto stampate dai quotidiani.
Una volta capitò una fotografia del Papa, con tutta la gente che gli si inginocchiava intorno. “Guarda tutti questi esseri umani” disse mio padre. “Qui c’è un essere umano in piedi, e tutti gli altri stanno in ginocchio davanti a lui. Dov’è la differenza? Questo qui è il Papa” – ce l’aveva in odio, il Papa – “la differenza sta nel vestito”.
Probabilmente il padre di Feynman pensava che le parole fossero il vestito delle cose – non l’essenza delle cose – e quindi aveva abituato il figlio fin dalla più tenera età a considerarle con grande sufficienza, inducendolo a rimarcare “la differenza” – come scrive egli stesso – “tra conoscere il nome di una cosa, e conoscere una cosa”.
Si sbagliava. Le parole e le cose sono i due lati di una stessa medaglia. Purtroppo Feynman contrasse una grande sfiducia verso chi maneggia le parole, ma alla fine dovette arrendersi – forse senza rendersene conto – al fatto che ciò che si sa delle cose è ciò che di esse si riesce ad esprimere con le parole. La fama del ruvido scienziato yankee, infatti, oltre che sul premio Nobel meritato nel 1965 riposa in buona parte sulle leggendarie lectures di fisica che egli tenne oltre cinquant’anni fa al Caltech (California Institute of Technology) di Pasadena e che ancora oggi vengono ripubblicate per la ricchezza e la profondità dei concetti contenuti, ma anche per la chiarezza insuperabile dell’esposizione. Feynman possedeva una istintiva e formidabile abilità espressiva – oltre che una buona dose di spirito – che gli consentiva di esporre idee difficili con parole semplici ma di grande efficacia.
Sebbene fossero apparentemente contrapposti, insomma – Feynman da un lato e Galileo (col conforto di Ariosto) dall’altro – elessi questi due scienziati come numi tutelari dell’ardua impresa che mi ero ripromesso di intraprendere, ovvero quella di insegnare agli studenti come stendere la relazione di laboratorio.
Ma perché ero tanto convinto che è difficile scrivere una relazione di laboratorio? In realtà non è affatto difficile scrivere una orribile relazione: qualsiasi studente ci può riuscire in qualunque momento, perfino a occhi chiusi; anche una cattiva relazione è una cosa abbastanza facile da scrivere e con un po’ di impegno quasi ogni studente può farcela da solo; una relazione mediocre, invece, comporta già numerose difficoltà, anche se in genere allo studente sembra vero proprio il contrario; una buona relazione invece è una impresa che richiede cognizione, esperienza e applicazione, e spesso uno di questi tre ingredienti manca; un’ottima relazione, infine, è un atto creativo, ovvero un buon lavoro con l’aggiunta di un contributo originale che è del tutto imponderabile a priori.
Io volevo insegnare a tutti gli studenti come si scrivono buone relazioni, incoraggiando al tempo stesso quelli più dotati a cimentarsi nella stesura di ottime relazioni. (Naturalmente, in subordine, mi sarei accontentato anche di relazioni mediocri).
Avevo individuato, in linea generale, due difficoltà fondamentali da superare per riuscire a ottenere dei buoni risultati:
1. bisogna riunire in un elaborato scritto molti elementi diversi che richiedono ciascuno delle abilità particolari (organizzare, riassumere, spiegare, descrivere, disegnare, calcolare) e bisogna farlo – come se non bastasse – in maniera chiara, armonica ed equilibrata; questa è la difficoltà tecnica;
2. bisogna presentare il proprio lavoro a una persona (il professore) il quale dovrebbe saperlo fare almeno tre volte meglio di chi glielo presenta (lo studente): una messa in scena imbarazzante e per molti aspetti grottesca; questa è la difficoltà psicologica.
Era necessario pertanto affrontare con impegno sistematico tutti gli aspetti della difficoltà tecnica senza sottovalutare la difficoltà psicologica che è insidiosissima, e dunque terribilmente difficile da superare – forse più di quella tecnica – come sospettavo quell’estate e come ho avuto modo di verificare di persona in mille occasioni diverse.
La difficoltà tecnica, come ho detto, in realtà è costituita da una intera galassia di innumerevoli difficoltà di varia grandezza, dominata dal buco nero dell’oscurità verbale.
‒ Qual è la figura retorica che lo studente impiega con maggiore generosità? – mi domando oggi, a sette anni da quell’estate, e rispondo con prontezza assoluta – l’ellissi, naturalmente.
L’ellissi, come è noto, è l’omissione nel discorso di parole o di intere frasi: la figura tende ad oscurare il significato del discorso ma lo rende più efficace. In campo letterario. Ecco infatti che ne ho appena scodellata una, esprimendo ellitticamente il fatto che nel campo della belle lettere un ponderato risparmio di sostanza verbale rende più efficace il discorso. Ma nel campo della letteratura tecnico-scientifica il ricorso all’ellissi è semplicemente devastante. Si può tollerare tutt’al più qualche educata metafora (“la pancia della curva…”), qualche pietosa litote (“non si può dire di aver ottenuto un buon risultato…”), ma l’ellissi è assolutamente deprecabile, perché non ti fa capire nulla. Purtroppo – parlo per esperienza personale – espungere da un testo tecnico-scientifico qualsiasi ombra di descrizione o di ragionamento ellittico è un’impresa titanica, anche per un professionista esperto della materia, figuriamoci per uno studente.
La difficoltà psicologica non è meno seria di quella tecnica. Immaginiamo la scena. Il docente ha spiegato a lungo al discente come stanno le cose e poi ha fatto il riassunto del discorso, prosciugandolo fino a ridurlo a una frase lapidaria; allora ha scostato leggermente il velo che copre il tesoro della sua dottrina e gli ha mostrato che quanto gli ha appena elargito, in realtà, non sono che poche briciole di quanto ci sarebbe ancora da dire; dopo ha ripreso il discorso, lo ha capovolto, lo ha nuovamente raddrizzato e lo ha sottoposto alla prova del paradosso; ha anche divagato, ma poi è tornato a bomba, preciso come un missile, e alla fine ha rivolto allo studente questa precisa richiesta:
‒ Ripeti.
Ripeti? Ammettiamo pure che lo studente abbia assorbito abbastanza dottrina per farlo; ma come fa a ripetere a chi è stato messo lì apposta per sopravanzarlo e che alla prima incertezza si affretterà a correggere e a precisare? C’è un notevole scoglio psicologico che ingombra il flusso della ripetizione studentesca sul quale, secondo me, non si riflette mai abbastanza. Del resto, anche volendo rifletterci sopra, non cambia un granché: così è la scuola. Si può immaginare uno scenario diverso? Certamente, eccolo.
Il docente ha appena terminato una estenuante ma fondamentale spiegazione: ha parlato per quarantasette minuti filati, ha riempito due lavagne e mezza, ha consumato sei centimetri di gesso, ha essiccato una gola e stremato due dozzine di cervelli. Finalmente si ferma, sfinito, posa quel che rimane del gesso sulla cattedra e pronuncia la fatidica domanda:
‒ Avete capito?
‒ Sì, prof, abbiamo capito – rispondono lietamente gli studenti in coro, detergendo il sudore dalle fronti.
‒ Bene – conclude il docente – allora domani parleremo del prossimo argomento.
‒ Niente verifiche? – arriva una domanda dai primi banchi.
‒ Che bisogno c’è? – si sorprende il docente – avete capito…
‒ D’accordo, prof – osserva uno studente al penultimo banco vicino alla finestra – però se io potessi ripetere quello che ho appena ascoltato mi persuaderei meglio del fatto di aver compreso bene il suo discorso.
‒ Hai ragione – ammette il docente – ripeti pure.
Via, non scherziamo. Lo studente fatica a ripetere prima di tutto perché ripetere è difficile e poi perché è ancora più difficile farlo davanti a chi ne sa più di lui. Quindi allude.
Anzitutto lo studente allude quando non ha capito oppure non ha studiato, perché in questo modo cerca di solleticare la vanità del docente che spesso non sa resistere alla tentazione di sostituire la propria facondia ai balbettii dello studente.
Ma lo fa anche in perfetta buonafede, quando ha studiato e crede di sapere. A quella zampillante fonte di sapienza che è il professore egli tende perciò solo ad accennare, ad additare, a nominare quello che sa, ben raramente a descrivere e a spiegare. E in fondo non ha tutti i torti, perché se lo facesse gli sembrerebbe un po’ come spiegare a un eschimese che cos’è la neve.
Ma di questo e di altri numerosi problemi, in quel momento, avvertivo confusamente solo l’esistenza. Di lì a poco avrei avuto tutto il tempo, del resto, per sbatterci contro il naso. Nel frattempo, infatti, era arrivato il 31 agosto e come ogni insegnante io provavo quell’ambiguo sentimento di sazio languore di chi non sa appagarsi di qualcosa che tuttavia lo ha lungamente nutrito. Sto dicendo insomma che erano finite le vacanze estive e che si doveva tornare a lavorare.
Questa volta, però, la situazione era un po’ diversa dagli anni passati: avevo preso molto sul serio il già nominato articolo 5, comma 1, lettera a e ci avevo riflettuto sopra per buona parte di quell’estate ormai al declino. Ero quindi moderatamente ansioso di mettere alla prova il mio progetto didattico nuovo fiammante.