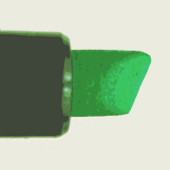Inverno: la riflessione
24. La descrizione dell'esperimento: se non lo so dire, non lo so
L’esperimento con la lasagna è l’ultimo della prima classe. In seconda, in genere, si chiude il discorso sui liquidi e si incomincia quello sulla calorimetria.
Vengono allora esperimenti sulla legge fondamentale della calorimetria, sulla misura del calore specifico, del calore latente di fusione (vedi la lista degli esperimenti in Solo esperimenti quantitativi). Le apparecchiature da impiegare sono più semplici della indigesta lasagna, tuttavia neppure il calorimetro delle mescolanze – tanto per fare un esempio – è un oggetto da sottovalutare quando si tratta di descriverlo.
In generale, insomma, quello della descrizione – sia che riguardi un apparato, uno strumento, oppure un procedimento – è uno scoglio molto difficile da superare da parte di molti studenti, anche se sono ben dotati sul piano delle capacità di ragionamento e delle abilità matematiche.
Eccomi di nuovo, dunque, con il foglietto delle topiche in mano a combattere questa volta contro un nemico insidiosissimo: lo scetticismo. Lo scetticismo studentesco, che viene associato spesso ad un sordo sentimento di rassegnazione, consiste essenzialmente nel considerare sinonimi due verbi che invece sono separati da una grande differenza di significato: capire e sapere.
È certo che il rimprovero rivolto con più frequenza agli studenti di tutte le classi, di tutte le scuole, di tutti i luoghi, di tutti i mondi possibili, compresi quelli migliori, concerne un difetto di attenzione.
‒ State attenti! – è il grido di battaglia del docente che sta per incominciare un discorso – Altrimenti non capite.
Poniamo il caso, perciò, che un certo studente si impressioni a quel grido e si disponga con diligenza a prestare l’attenzione richiesta; ebbene, quando lo fa non è raro che, se il docente non è proprio un asino, egli effettivamente capisca. Questo significa che lo studente prova quel piacere intellettuale che si prova quando la mente riesce ad abbracciare – per un istante, ma nel suo insieme – il tracciato di un sinuoso percorso logico.
Questo piacere intellettuale che tutti abbiamo provato, tuttavia, alle volte può essere fuorviante, e nel caso degli studenti lo è in modo sistematico. Per loro, infatti, l’esperienza di cogliere per un istante il senso generale del discorso equivale automaticamente a ritenere di essere diventati padroni di quel discorso.
‒ Avete capito? – domanda il docente alla fine della spiegazione.
‒ Sì – risponde spesso lo studente, ma egli mente in buonafede.
Il docente esperto, infatti, sa che dietro quella risposta affermativa si cela, il più delle volte, una menzogna che sarà molto difficile smascherare, a causa soprattutto della buonafede, che è sempre una dimostrazione di onestà ma talvolta è anche un grave impedimento alla verità.
Eppure, quel delizioso brivido intellettuale che si prova nell’afferrare un concetto dà poi a tante persone, e soprattutto agli studenti, la fallace e vorrei anche dire inaudita certezza che sì – invece – sì che saprebbero ripetere il discorso appena udito, come Chuang-Tzu seppe disegnare il granchio davanti al re.
Questo episodio della vita di Chuang-Tzu è molto istruttivo e merita perciò di essere raccontato. Eccolo, come lo riporta Italo Calvino nelle proprie Lezioni americane.
Tra le molte virtù di Chuang-Tzu c’era l’abilità nel disegno. Il re gli chiese il disegno di un granchio. Chuang-Tzu disse che aveva bisogno di cinque anni di tempo e d’una villa con dodici servitori. Dopo cinque anni il disegno non era ancora cominciato. “Ho bisogno di altri cinque anni” disse Chuang-Tzu. Il re glieli accordò. Allo scadere dei dieci anni, Chuang-Tzu prese il pennello e in un istante, con un solo gesto, disegnò un granchio, il più perfetto granchio che si fosse mai visto.
Io amo perdutamente questa storia. Che cosa ha fatto Chuang-Tzu durante quei dieci lunghi anni di comodità e di distacco dalle incombenze quotidiane? Secondo me Chuang-Tzu si è dedicato soprattutto a pensare. Dopo aver lungamente e attentamente osservato i granchi, infatti, in tutte le maniere possibili, alla fine egli deve aver cercato di costruire dentro di sé un’immagine del granchio.
All’inizio doveva essere un’immagine piuttosto approssimativa, ma poi, piano piano, questa immagine è diventata sempre più chiara e precisa, grazie al lavorio continuo di pulizia del profilo di quel granchio che Chuang-Tzu andava imprimendo nella propria mente. Dopo questa intensa applicazione, perciò, Chuang-Tzu è arrivato a possedere l’idea del granchio con una chiarezza tale da poterlo disegnare in un istante e con un solo gesto. Penso che se il re gli avesse chiesto di disegnarlo bendato non lo avrebbe disegnato meno perfetto.
Ora, io non voglio sostenere con questo discorso che per scrivere una relazione di laboratorio bisogna stare a pensarci su almeno dieci anni, oppure che bisogna trovare il Tao per venirne a capo, però la storia di Chuang-Tzu spiega bene che le difficoltà non vanno mai sottovalutate, mentre è risaputo che gli studenti sono imbattibili nel minimizzare i problemi. Emilio Matricciani, nei suoi Fondamenti di comunicazione tecnico-scientifica (p. 5), ha scritto un’altra cosa che mi piaciuta tantissimo:
Nessuno, infatti, sa con precisione ciò che pensa finché non lo esprime con parole scritte o pronunciate.
È proprio così. Ciò che si sa veramente emerge solo nel momento in cui si cerca di esprimerlo. Ecco perché Chuang-Tzu ha avuto bisogno di tanto tempo per disegnare il granchio. Probabilmente gli appariva vile l’idea di provare e riprovare col pennello fino al momento di ottenere un risultato accettabile; non aveva altra strada, perciò, che quella di pensare il granchio con tale chiarezza da essere certo poi di disegnarlo con altrettanta perfezione.
Agli studenti io non chiedo tanto – e d’altra parte io non sono il re – ma duro la mia bella fatica a spiegare che il fatto di aver provato la fugace sensazione di capire e il sapere stabilmente un concetto sono due cose molto differenti, e che non c’è altro modo per verificare le proprie conoscenze se non quello di esprimerle verbalmente, a voce o per iscritto.
A questo proposito ho coniato anche uno slogan: se non lo so dire, non lo so, che in genere li fa infuriare terribilmente perché, ai loro occhi, mette in discussione la loro buonafede.
‒ Lo so, ma non lo so dire – è una loro tipica giustificazione – ho capito, ma non lo so dire.
‒ Se non lo sai dire – è la mia sprezzante risposta – allora vuol dire che non lo sai.
E qui bisogna ammettere che molti colleghi cadono pietosamente nella trappola che gli studenti tendono loro:
‒ Ho capito, ma non lo so dire – si giustifica lo studente in difficoltà.
‒ Va bene, non preoccuparti – lo scagiona il docente – Prova a dirlo con le tue parole.
Che cosa significa: con le tue parole? Quali altre parole potrebbe usare lo studente se non le proprie, come chiunque del resto? Oppure il docente vuol dire un’altra cosa:
‒ Balbetta pure, figliolo. Accenna, abbozza, alludi, arronza. Ti prometto che se capisco vagamente che cosa vorresti dire, allora sei salvo.
Ahimè, buonafede e pietà servono a poco quando si tratta di sapere le cose. La questione sta semplicemente in questi termini: o le sai, o non le sai. Naturalmente la chiarezza con cui le cose sono possedute dalla mente non è sempre la stessa; tuttavia c’è una soglia espressiva al di sotto della quale è legittimo dichiarare, anche se è un po’ crudele:
‒ Non lo sai.
Un momento. Ci sono fior di cervelloni che non sanno esprimersi, però le cose le sanno benissimo. Una collega di fisica, una volta, mi disse che quando studiava a Padova – nell’università che fu di Galileo – c’era un docente soprannominato dagli studenti mi spezzo ma non mi spiego per la sua proverbiale incapacità di farsi capire. Vogliamo forse sostenere che non sapesse la fisica? Certo che no, ma bisogna sgomberare il campo da un possibile equivoco.
C’è un sapere cognitivo ben distinto da un sapere operativo, ed entrambi, comunque, sono cosa ben diversa dalla sensazione di sapere che ci procura il fatto di essere riusciti a seguire una lunga spiegazione senza perderci. Il sapere operativo è sinonimo del saper fare, cioè della capacità materiale di eseguire un compito, sia un salto mortale, sia l’integrazione di un’equazione differenziale: se lo sai fare, lo sai (fare) e non c’è evidentemente molto da aggiungere.
Il sapere cognitivo, invece, è quello che si può misurare con la capacità di esprimerlo verbalmente. Ebbene, tutto il sapere può essere operativo, ma non tutto il sapere può essere cognitivo. Infatti non si può spiegare la competenza ad eseguire un salto mortale, dal momento che buona parte di questa competenza risiede, per così dire, nel corpo, mentre è possibile spiegare minuziosamente come si integra un’equazione differenziale poiché questa competenza risiede interamente nella corteccia cerebrale.
Non tutti sono chiamati ad esprimere un sapere cognitivo. Un pizzaiolo deve saper fare la pizza e non è necessario che sappia spiegare come ci riesce. Un insegnante, al contrario, deve manifestare al massimo grado il proprio sapere cognitivo; si può dire che tutto il suo sapere operativo deve essere convertibile in sapere cognitivo, altrimenti egli non è un insegnante, come il nominato professore padovano.
Fra questi due estremi ideali possiamo pertanto collocare tutta la sterminata massa di competenze professionali costituitasi fino al giorno d’oggi: astronauti, conferenzieri, confessori, dirigenti, ingegneri, medici, paracadutisti, pasticceri, poeti, programmatori, pubblicitari, sarti, trombettisti, viticultori, e via discorrendo: è evidente che per alcune di queste categorie professionali il sapere cognitivo appare una ben piccola necessità, mentre per altri si presenta come una risorsa molto più importante.
Rimane il fatto, però, che la scuola, secondo il mio parere, è chiamata prima di tutto a stimolare la costituzione di un sapere cognitivo, e solo in subordine e strumentalmente deve promuovere e coltivare quella di un sapere operativo. La tendenza dello sviluppo sociale, infatti, mostra chiaramente che l’attitudine alla flessibilità, alla comunicazione e al lavoro in gruppo sono abilità sempre più apprezzate, e non è difficile comprendere che il sapere cognitivo promuove sensibilmente queste abilità, mentre quello operativo tende inevitabilmente a mortificarle.
Il tempo dedicato a spiegare e a descrivere quello che si sa, perciò, non è tempo perso, ma rappresenta invece un esercizio fondamentale per mettere alla prova le proprie cognizioni. In particolare, per scrivere la descrizione dell'esperimento (vedi lo schema di stesura già più volte citato) è buona norma attenersi ad una precisa formula.
Quando faccio quest’ultima affermazione in classe, con il foglietto delle topiche in mano, subito dopo prendo il gesso, vado alla lavagna e scrivo:

dopodiché dichiaro con un certo fervore:
‒ Ecco, questa è la formula per scrivere bene la relazione di laboratorio. Imparatela.
La prima volta che vedono questa formula gli studenti mi guardano con molta perplessità, e io confesso di godermi per qualche istante il loro comprensibile smarrimento. Poi spiego, e nel frattempo indico i simboli con il dito, uno dopo l’altro:
‒ La Relazione È Un Mezzo per esprimere la Memoria Verbale di un Vissuto.
Cinque minuti dopo, quando sto già parlando d'altro, c’è sempre qualcuno che si batte la fronte per esclamare:
‒ Ah, adesso ho capito!
Proprio così. Una relazione è un mezzo per esprimere la memoria verbale di un vissuto. Essa serve per raccontare, servendosi essenzialmente delle parole, un evento del quale si è stati testimoni. Nel caso particolare in cui l’evento sia un esperimento scientifico, allora è giusto parlare di rendiconto scientifico o, più modestamente, di relazione di laboratorio.
Incontro molte difficoltà a convincere alcuni colleghi del fatto che una relazione scientifica debba presentarsi come un racconto, ovvero che essa costituisca un genere letterario di carattere narrativo. Il carattere universale di ogni valida nozione scientifica, infatti, sembra non andare d’accordo con la narrazione di una storia la quale – quasi per definizione – suscita un’idea di particolarità, assai poco consona al moderno sapere scientifico.
Ecco, allora, che qualcuno trova preferibile che l’autore si celi dietro un neutro parlare in terza persona, che impieghi il presente storico che appiattisce tutte le difficoltà e le incertezza patite in una esposizione senza emozioni e soprattutto priva della dimensione temporale.
Non mi sembra giusto. Questo modo di esprimere le idee va bene in un manuale, dove la materia è espressa in maniera sistematica e definitiva, ma non si addice affatto al resoconto di una attività appena svolta, dove la realtà palpitante degli insuccessi e dei successi non va imbalsamata in periodi asettici e compassati. Qualcuno sta per chiedere:
‒ Che cosa può esserci di palpitante nella legge di Boyle, una legge nota fin dal xvii secolo?
C’è l’emozione della scoperta, che rappresenta una rivelazione impareggiabile per chi la fa, anche se si tratta di uno studente di liceo che s’imbatte in una nozione arcinota; semmai, sta al suo insegnante evitare in tutti i modi di mortificare l’emozione che una scoperta dovrebbe produrre.
E poi, se è dai tempi di Eraclito che andiamo dicendo che non ci si bagna mai due volte nello stesso fiume, io credo che si possa parafrasare il suo insegnamento sostenendo che è impossibile fare due volte lo stesso esperimento. Davvero, è impossibile.
Chi ha provato a mettere piede in un laboratorio sa bene che non è possibile clonare un esperimento. C’è sempre qualcosa che prende una strada inattesa, e alla fine ogni risultato è diverso dal precedente. Quello che conta, naturalmente, è il risultato statisticamente significativo, ma ogni singolo esperimento fa caso a sé, dunque è doveroso raccontarlo per quello che è stato.
Il fondatore del genere letterario in questione – il rendiconto scientifico – la pensava proprio così, e devo ammettere che questo, per me, è stato un grande conforto. Nell’Annunzio sidereo, infatti, Galileo essenzialmente racconta le proprie scoperte.
Altre cose forse più importanti saranno col tempo o da me o da altri scoperte con l’aiuto di un simile strumento [il telescopio], la cui forma e struttura come anche l’occasione di inventarlo, esporrò prima brevemente e dopo racconterò la storia delle mie osservazioni.
Inoltre, questa storia è raccontata con parole commosse, sebbene misurate, temperando l’emozione e l’orgoglio di cui era comprensibilmente pieno il cuore di chi le scriveva.
Quanti e quali siano i vantaggi di questo strumento, così per terra come per mare sarebbe del tutto superfluo enumerare. Ma io, lasciando le cose terrene, mi rivolsi alla speculazione delle celesti, e prima mirai la luna così da vicino, come se fosse distante appena due semidiametri terrestri. Dopo questa osservai più volte con incredibile godimento dell’animo le Stelle, tanto fisse che erranti.
Contrastano piacevolmente quei due semidiametri terrestri con l’incredibile godimento dell’animo che produce l’osservazione al telescopio, ma non sorprendono, perché l’attività scientifica è sempre un esercizio di controllata meraviglia.
Il racconto rende giustamente conto anche di alcune incertezze, e si sviluppa perciò con un andamento che non risulta sempre lineare. Infatti, quando Galileo osservò per la prima volta i pianeti di Giove – che dell’Annunzio sidereo sono la notizia più importante – non li riconobbe subito, ma li confuse con piccole stelle fisse.
Qui, per quanto non volgessi affatto il pensiero al reciproco avvicinamento delle Stelle [i pianeti] cominciai tuttavia a soffermarmi sul dubbio, in che modo Giove potesse trovarsi a oriente di tutte le fisse predette, quando il giorno prima era ad occidente di due di esse: e perciò temei non fosse per caso diretto, diversamente dal computo astronomico, e perciò col moto proprio avesse preceduto quelle stelle. Perciò col più gran desiderio aspettai la notte seguente; ma fui deluso nella mia speranza, perché il cielo fu da ogni parte ricoperto di nubi.
Saranno tutti d’accordo, presumo, sul fatto che le ultime due frasi sono assolutamente inutili nell’economia scientifica del rendiconto, però esse sono fondamentali nell’economia emotiva dello scopritore, perché sottolineano un passaggio fondamentale del piacere della scoperta fino alla conquista finale, dopo che Galileo ha raggiunto la certezza che non di stelle fisse si tratta, bensì di pianeti erranti.
Ormai mutando la perplessità in meraviglia, fui certo che l’apparente mutamento non in Giove era riposto, ma nelle Stelle osservate.
Mutare la perplessità in meraviglia è ciò che mi sforzo costantemente di indurre negli studenti, incoraggiandoli a documentare per iscritto questo stato d’animo, persuaso del fatto che solo così essi potranno dimostrare – prima di tutto a se stessi – che ciò che hanno capito è diventato anche un patrimonio personale, prezioso e intangibile.
Il foglietto delle topiche, tuttavia, spesso mi appare un’arma molto modesta per combattere la battaglia a favore di una scienza raccontata in temperate parole.
Una delle voci che vi compare più spesso, per esempio, è proprio l’equazione appena riportata, che mi appunto quasi ogni volta, relazione dopo relazione, a mo’ di promemoria. Duro molta fatica, per esempio, a convincerli del fatto che poiché devono raccontare l’esperimento svolto, cercando di ripercorrere per iscritto la memoria di ciò che hanno vissuto, è buona norma usare il tempo passato.
Il tempo presente possono riservarlo alla premessa, dove è necessario richiamare dati e notizie che sono ormai un patrimonio acquisito, e quindi che si adatta ad essere trattato con il presente storico. Il futuro va proprio evitato. Non c’è alcuna ragione per usare questo tempo, perché scrivendo la relazione difficilmente ci si trova nella necessità di fare riferimento a qualcosa che verrà. Quindi: tempo passato, possibilmente prossimo.
Ma qualcuno non resiste alla tentazione dell’imbonitore e si avventura a premettere al proprio pubblico che prima andrà a misurare questo, poi andrà a calcolarsi quest’altro, e via discorrendo.
‒ Ma scusa – domando ogni volta, per l’ennesima volta – se hai già svolto l’esperimento, e hai già eseguito i calcoli, perché non scrivi semplicemente quello che hai già fatto?
Come mi succede spesso, sopravvaluto il valore dell’ovvietà, anche se questo discorso fortunatamente non vale per tutti. Molti studenti, infatti, comprendono bene la necessità di raccontare l’esperimento e adattano facilmente il proprio discorso allo stile narrativo nel quale, talvolta, non mancano la sorpresa e lo stupore di galileiana memoria. Ma altri resistono indomiti ai miei assalti, sfoderando per confondermi tutte le forme verbali che conoscono.
È difficile credere che dopo aver letto in classe una descrizione dell’esperimento volta scrupolosamente al passato e aver ripetutamente ricordato che una relazione è un mezzo per esprimere la memoria verbale eccetera eccetera, qualcuno possa ancora azzardarsi – sissignore – ad andare a incominciare. Eppure è così.
Ma è pur sempre la descrizione dell'esperimento, vale a dire l’esposizione ponderata dell’aspetto e del funzionamento di un certo apparato l’ostacolo contro il quale si spuntano le deboli armi verbali dello studente. Finché si tratta di allineare una sequenza di eventi, infatti, il risultato è sopportabile, magari con buona pace dei tempi verbali e di interminabili concatenazioni di poi e di dopo. Ma descrivere un oggetto è un problema di tale difficoltà che anche se ne ho già parlato (Lasagne a scuola) vorrei tornarci sopra ancora un poco.
Poco chiara, poco precisa; troppo generica, troppo dettagliata: una descrizione ha sempre qualcosa di meno o qualcosa di troppo, come una scultura malriuscita, e ci vuole un piccolo Michelangelo per scolpire una descrizione perfetta. Figuriamoci gli studenti, i quali non possiedono affatto la pazienza necessaria per applicarsi con accanimento intorno ad una descrizione. A loro, in più, li frega l’egocentrismo sempre in agguato che non hanno ancora imparato a dominare, né mai impareranno, alle volte.
Se esistesse un cubismo verbale, infatti, possiamo stare sicuri che sarebbe affare degli studenti coltivarlo col massimo impegno. Ebbene, guarire dall’egocentrismo è la scommessa della maturità, però non si guarisce in un colpo solo, ma a piccoli passi. Io cerco di fargliene fare uno, per esempio, sottoponendo loro un mio modesto cimento di cubismo verbale. Sul mio foglietto delle topiche, perciò, annoto la descrizione di un comune oggetto d’uso e gliela leggo:
L’oggetto è composto da tre pezzi di plastica non piatti ma con dei bordini, alcuni dei quali sono zigrinati, cioè hanno una leggera seghettatura che si avverte al tatto.
Il primo pezzo ha al centro dodici dentini disposti su una circonferenza ed è incastrato dentro il secondo pezzo.
Il terzo pezzo, invece, è attaccato al secondo pezzo per mezzo di due perni che si innestano in due fori che si trovano in due stanghette molto delicate.
‒ Che cos’è? – domando alla fine, mentre mi godo lo smarrimento generale.
È evidente che nessuno ha la più pallida idea di che cosa si sta parlando. Ascolto le risposte più inverosimili.
‒ Quando ve lo dirò – rincaro – resterete molto stupiti.
Altra infornata di sparate, più o meno a caso. Quando l’immaginazione comincia a dare qualche segno di affaticamento, svelo l’arcano.
Niente da fare. È la custodia di un cd-rom. Adesso ve la rileggo. Vi accorgerete che non ho trascurato alcun dettaglio della custodia, tuttavia si tratta di una descrizione demenziale, più o meno come quelle che scrivete voi, confezionate idoleggiando il vostro inaccessibile punto di vista personale.
Qualche piccola breccia nella soggettività studentesca sembra aprirsi, ma la strada è sempre lunghissima. Per fortuna ci sono i disegni, che dovrebbero essere un appoggio alla descrizione verbale. Ma qualcuno riesce a ingarbugliare le cose anche in questo caso.
‒ Scusa, Alex – domando a uno studente che non si sente abbastanza sicuro della sua abilità nel disegno – ma che bisogno c’era di descrivere a parole il disegno di un circuito elettrico? – e poi leggo – “Dal generatore parte un filo che è collegato ad una resistenza, all’altra estremità della quale sono collegati due fili che a loro volta sono collegati…”
‒ Eh, già, prof, che bisogno c’era?