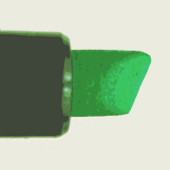Primavera: la maturità
39. Ma quanti studenti ho incontrato?
Mi fa un effetto singolare scorrere lista degli studenti che hanno fatto la relazione sulle basi fisiche del suono e sull’esperienza musicale (Matematica, fisica e musica).
Alla base di dati ho impartito questo comando: mostrami la lista di tutti gli studenti che hanno svolto questa relazione in ordine di voto decrescente e – a parità di voto – in ordine alfabetico. La base di dati mi restituisce in un istante la lista richiesta ed io posso procedere al ragionamento su di essa, ma quelle 153 voci non parlano solo all’intelligenza, parlano anche alla memoria e al sentimento.
Il primo della lista è Davide: si è diplomato quest’anno, è bravo, suona la chitarra e vuole fare l’ingegnere. Ma il secondo della lista – Pietro – è già più lontano nella mia memoria, perché ha fatto l’esame l’anno scorso; però mi ricordo che anche lui suonava la chitarra. La portò in laboratorio per fare l’analisi armonica del suo suono e alla fine ci diede un saggio della sua arte: suonava senza pretese, però a scuola era bravo.
E poi vengono Francesco, Sarah, Domenico: emergono tutti istantaneamente al richiamo della coscienza, grazie al lieve sforzo che la memoria compie per ricondurre i volti e i caratteri di questi studenti al centro dello spazio mentale, ovvero in quel punto speciale che si chiama adesso. È un continuo andare avanti e indietro nello spazio interiore, un leggero viavai senza rumore e quasi senza fatica: Fabio, diplomato tre anni fa; Paolo, anche lui diplomato tre anni fa; Lidia, quattro anni fa; Daniele, l’anno scorso; Giovanni è ancora in quinta.
Poi arriva Marco e il compito della memoria si fa più difficile: Marco si è diplomato quasi sette anni fa, e forse per questo non me lo ricordavo.
Non mi sono completamente dimenticato di Marco, però non me lo ricordo come Davide. Davide è praticamente qui, davanti a me, solo un po’ discosto. Dal punto di osservazione della mia coscienza lo vedo quasi senza dover impegnare la memoria. È lì, lo scorgo. Non penso più a lui almeno una volta alla settimana, ma è bastato che la base di dati lo incasellasse nella lista, grazie al suo meccanismo infallibile, affinché io potessi sollevare gli occhi e vederlo davanti a me:
‒ Ciao, Davide, stai studiando o suoni la chitarra? È Smoke on the water dei Deep Purple, come quella che sono venuto a sentirti al tuo concerto?
Con Marco, però, le cose non stanno così. Marco non me lo ricordavo. Ora mi è tornato alla mente, questo è vero, ma la memoria ha avuto un certo daffare per cercarlo in quella zona crepuscolare del spazio mentale che non è subito evidente alla coscienza. Anche Marco è stato un bravo studente, ma l’immagine che me ne restituisce la memoria non è così vivida come quella di Davide; per esempio, non riesco a ricordare bene il suo volto. Sento una piccola stretta al cuore perché mi sembra di aver perso qualche cosa di me.
Pare che si dimentichi ciò che si vuole dimenticare, pur senza farlo consapevolmente; forse, allora, la mia memoria si è disfatta di una parte del ricordo di Marco, senza mettermi al corrente mentre lo faceva. Lo ha fatto magari per dare risalto a ricordi più utili.
Ma in realtà io non ho affatto dimenticato Marco. Il suo ricordo, infatti, era solo depositato nell’anello crepuscolare della mia memoria e da quel luogo esso può tornare alla coscienza, sebbene in modo alquanto difettoso.
Con la base di dati ciò che conta è la qualità della richiesta: se essa è abbastanza precisa il ricordo affiora con tutta la chiarezza possibile, altrimenti non se ne vede neppure l’ombra. Con la memoria, invece, contano anche la pazienza e la sagacia, cioè la capacità di attendere che l’immagine prenda corpo, via via che la si sfiora col pensiero, e l’accortezza di collegarla a qualche particolare concomitante.
Marco faceva parte di una classe con la quale non sono mai riuscito ad intrattenere un rapporto di vera cordialità. Non ero solo io a lamentarmi di ciò, lo dicevano molti altri colleghi; era una classe un po’ chiusa in se stessa, silenziosa, distante, a volte sdegnosa. Marco era fra i migliori e fra i più riservati. Ecco, adesso, in questo preciso istante, sono riuscito finalmente a intravvedere il suo volto: gli occhiali, la faccia seria da bravo ragazzo studioso. E ricordo anche un episodio curioso: ormai non più studente dell’istituto, Marco torna a salutare i suoi ex docenti; ride, scherza, si sbraccia a raccontare della sua esperienza di matricola e alla fine saluta con una cordialità assolutamente inattesa.
‒ Ma era proprio Marco quello che è venuto a trovarci? – ci domandiamo fra colleghi l’un l’altro dopo che se ne è andato.
Il piccolo incidente mnemonico con Marco mi induce a pormi una domanda quasi ovvia:
‒ Quanti studenti giacciono dimenticati nell’anello crepuscolare della mia memoria di insegnante, ormai più vicino alla pensione che alla nomina?
Sono tanti di sicuro, e la maggior parte di essi non potrà mai più essere richiamata alla luce della coscienza; resteranno confinati per sempre in quella zona indistinta della mia memoria dove – anno dopo anno – sono andati ad affollarsi, sospinti e purtroppo pigiati da quelli venuti dopo di loro.
Stimo di aver incontrato finora oltre duemila studenti nel corso della mia attività di insegnante. Potrei cercare di essere più preciso, ma perché mai dovrei farlo? Ciò renderebbe ancora più acuto il disagio dell’oblio. Sono convinto che se potessi disporre di una base di dati estesa a tutta la mia carriera potrei rinfrescare una massa imponente di ricordi sepolti ma non perduti. Ma purtroppo la mia base di dati risale solo a sette anni fa e quindi posso applicarla in maniera oggettiva e democratica solo ad una parte del piccolo popolo degli studenti che ho incontrato.
Del periodo in cui lavoravo al doposcuola, per esempio, conservo ancora il ricordo solo di pochi studenti. Sono quelli che si sono distinti per qualche cosa di speciale: uno di essi per la petulanza quasi soprannaturale, uno per la durezza del cuore ancora bambino, uno per la tenerezza con la quale esplorava col dito la fossetta del mio mento mentre mi sommergeva di domande. Ma di tutti gli altri, in apparenza, nulla è rimasto. Volti, caratteri, episodi e storie sono sprofondati per sempre nella parte oscura della mia memoria, destinati a sparire con essa stessa. Non sono sicuro, però, che questa sia una cosa del tutto negativa. In fin dei conti noi siamo quello che resta e se ciò può apparire crudele, a prima vista, in definitiva è solo necessario.
Non è detto, però, che non ci si possa aiutare affinché quello che resta sia un po’ di più di quello sarebbe lasciando semplicemente correre le cose verso il proprio destino. Eccomi perciò a interrogare nuovamente la mia base di dati, questa mia preziosa memoria accessoria, pronta e precisa, sebbene non così profonda come vorrei.
Il mio nuovo comando alla base di dati è: mostrami, in ordine alfabetico, la lista di tutti gli studenti che ho incontrato in questi ultimi sette anni. La base di dati, docile e fulminea, mi restituisce 320 nomi. È come se avessi davanti a me il registro di un’unica, sterminata classe. Sono sinceramente intimidito alla semplice idea di alzare lo sguardo e guardare questo avamposto delle migliaia che si perdono nell’oscurità della memoria.
Comincio il mio appello ideale. Già la prima voce dell’elenco costituisce una sorpresa, perché Benny era proprio uscito dalla mia memoria, apparentemente. Eppure ha un nome e un cognome che si ricordano, ma sono passati sette anni, e questo è bastato per confinarlo nella zona del crepuscolo. Benny era brillante e anticonformista, adesso me lo ricordo bene. Non credo che abbia mai amato particolarmente la fisica e la chimica, ma questo adesso mi appare un dettaglio marginale. Sarà riuscito invece a trovare un solco dove incanalare le proprie inquietudini?
Proseguo con l’appello. Paolo si è perso per strada: era intelligente, ma era incapace di applicarsi alla fatica dello studio; Raffaele è transitato come una meteora: di lui conservo solo il nome in un archivio informatico.
Vado avanti, e incontro una sorpresa penosa: c’è un Roberto che contende con Marco un nitido ricordo. I cognomi hanno qualcosa in comune e la mia memoria è indecisa: io sono costernato. Era stato forse Roberto – e non Marco – a tornare a salutare festosamente i propri docenti? Era stato Marco. Ho interrogato ancora la mia base di dati, chiedendo il profilo scolastico di Marco e di Roberto, e ho ricevuto notizie inconfutabili. Ma non posso nascondermi l’evidenza amara che la mia memoria ha fallito, almeno parzialmente. Con l’aiuto esterno ora sono riuscito a ricostruire meglio i volti di questi studenti e mi torna davanti alla vista, con più vivacità, l’euforia di Marco.
Con questa solida gruccia per la memoria che è la base di dati proseguo nell’appello. Incontro tanti studenti che riavrò davanti agli occhi in carne ed ossa domani mattina – Ambra, per esempio – ma ogni tanto, scorrendo la lista, m’imbatto in qualche altro caso particolare. Incontro di nuovo Emanuela Franti. Ma per ricordarmi di lei non ho bisogno della base di dati. Emanuela, in fondo, è stata l’ispiratrice di questo lavoro, la studentessa che ogni insegnante vorrebbe avere in ogni classe: intelligente e studiosa. Mi domando piuttosto se io sono riuscito a dare a lei l’equivalente di ciò che lei ha ispirato a me.
Giancarlo, al contrario, lo avrei evitato volentieri, come il medico eviterebbe il paziente tignoso; ma purtroppo non si può, e non sarebbe neppure giusto. Intelligente e borioso, ho sempre fatto una discreta fatica a tenerlo al proprio posto. Francesca, invece, non mi ha dato mai alcuna pena: lei semplicemente non pensava alla scuola, perché pensava di entrare nel mondo della moda. Di lei non ho mai potuto esaminare alcunché di scritto. Non ho potuto darle nulla.
Vado avanti. Altri studenti vicini, alcuni vicinissimi, altri lontani, lontanissimi. Mi rendo conto che sto scorrendo la lista molto rapidamente. In pratica mi fermo solo davanti al nome per un breve riconoscimento, e ho quasi la sensazione di compiere un’operazione piuttosto lugubre. Ma non è così. La verità è che questi studenti sembrano davvero troppi e appena rallento la corsa dell’occhio sulla lista, subito la mia mente si affolla di pensieri innumerevoli. Mi soffermo a caso su un gruppetto di tre studenti contigui, avvicinati solo dall’ordinamento alfabetico: Davide, un’altra Francesca, Andrea.
Davide era bravo; giocava anche in una squadra di calcio e vinceva. Non so come facesse, era un caso più unico che raro. In consiglio di classe eravamo sempre lì a ripetercelo tra colleghi, quando si trattava di parlare del suo profitto. Per il collega di educazione fisica Davide era la prova che studio e agonismo sportivo non sono in contraddizione, per me era l’eccezione che conferma la regola. Difatti alle volte prendeva delle cantonate sesquipedali, per esempio quando si applicava alla fatica mentale la sera tardi, dopo che – reo confesso – non si era risparmiato per tutto il pomeriggio in quella fisica.
Francesca era fragile e insicura. Era più brava di quel che credeva di essere, e infatti ogni volta che presentava un lavoro lo faceva come se consegnasse al botteghino del lotto i propri numeri vincenti. Spesso vinceva, ma non voleva accettare il fatto che la scuola non è una lotteria. Suonava il pianoforte, ma il voto più brutto lo ha preso nella relazione sulle basi fisiche del suono. Forse non è stato un caso.
Andrea si è perso, almeno ai miei occhi, dopo un paio d’anni. Era un ragazzone buono, che cresceva in statura, ma non altrettanto in sapienza. Se gli avessi detto che la funzione che esprimeva la quantità delle sue cognizioni in funzione del tempo trascorso non aveva un andamento lineare mi avrebbe guardato con il suo sguardo allegro e sempre un poco perso, chiedendomi a sua volta:
‒ Prof, in che senso?
Potrei andare avanti così per un pezzo. La mia base di dati potrebbe innescare a lungo questo esercizio sentimentale della memoria per rievocare, riflettere, farmi prendere dall’emozione e magari restare turbato al pensiero delle cose che sono successe, di quelle che potevano succedere e di tante altre cose che invece era meglio se non succedevano, ma alla fine dovrei ammettere che non riuscirei mai ad abbracciare con la mente tutti gli studenti che ho incontrato nel corso degli anni. Però non è vero il contrario. Un insegnante incontra migliaia di studenti, ma uno studente incontra solo qualche decina di insegnanti. Uno studente, perciò, non ha bisogno di un supporto esterno affinché i propri ricordi scolastici tornino quasi spontaneamente alla coscienza, gli basta chiudere gli occhi per rivedere gran parte dei propri insegnanti, i loro volti, i caratteri e gli umori.
La mia maestra di prima elementare si chiamava Margherita e aveva un cognome impronunciabile. Era magra ed era scura nei capelli e nel vestire; era severa ma ragionevolmente materna; di lei conservo soprattutto il ricordo del volto un po’ pallido, ma sempre ravvivato dalla bocca adorna di rossetto. In seconda elementare ebbi la maestra Delcati, che era buona e gentile e adesso mi sembra uscita dall’immaginazione di De Amicis, per via soprattutto di quel cognome dal suono tanto affettuoso. La terza elementare fu invece un po’ movimentata, quanto ad insegnanti: ne cambiarono parecchi e li ricordo senza particolare emozione.
Risalendo col ricordo ai miei insegnanti degli anni più remoti sono colto talvolta da un senso di disagio, soprattutto da quando ho appreso che i falsi ricordi sono una certezza statistica e quindi che ciò che crediamo di ricordare con sicurezza alle volte è solo abbastanza vero, oppure – se vogliamo – abbastanza falso.
Non sono veramente io, dunque, colui che io ricordo? La mia identità ha subito una progressiva deriva che, anno dopo anno, ora mi conduce a credere di me ciò che non è mai stato? Se buona parte di ciò che io sono è quello che io ricordo, e se questa parte di me è destinata a crescere, con il passare del tempo, fino ad occupare nella vecchiaia quasi la totalità del mio essere, mi chiedo con un certo sgomento chi io sia veramente, e se la maestra Margherita è mai esistita davvero, tanto è lontano in me il ricordo della sua bocca rossa che ha toccato il mio cuore di bambino. Forse il suo cognome non era davvero così impronunciabile come mi sono convinto che fosse, e forse non veniva a scuola proprio tutte le mattine con la bocca sobriamente dipinta di rosso, ma almeno una volta deve averlo fatto di sicuro, non può essere altrimenti, e il mio animo, quella mattina, doveva essere perfettamente disposto ad accogliere quell’evento come un episodio eccezionale che avrebbe depositato nel luogo più sicuro della memoria.
Che importa, dopotutto, se c’è una divergenza fra i miei ricordi e ciò che è stato veramente? Ma poi che cosa è stato veramente? La realtà concreta sono i miei ricordi, un impasto inestricabile fra ciò che è accaduto e l’attività riorganizzatrice della mia memoria che piano piano ha modellato quello che sono, quello che faccio e quello che ora racconto. Se a qualcuno tutto ciò interessa, allora vuol dire che esiste realmente.
Della mia prima maestra, Margherita, il ricordo può anche essere sbiadito a tal punto da farmi perfino dubitare del suo rosso sorriso, ma del maestro Pennino, che ebbi in quarta e in quinta elementare, la mia memoria conserva un ricordo inoppugnabile. Questo maestro, che aveva un nome così garbato che sembra uscito da una favola di Rodari, era in realtà un mascalzone il quale, per la prima volta nella vita, mi dimostrò che gli insegnanti non erano tutti operosi ed amabili, come avevo creduto fino a quel momento, ma che c’erano anche gli infingardi, i violenti e i disonesti. E di queste tre categorie egli rappresentava una spregevole sintesi. Non si ammazzava di lavoro – ma questo era solo il lato migliore del suo carattere – e se noi scolari non sapevamo impossessarci rapidamente dei frutti della sua modesta operosità, venivamo sottoposti a odiose e sistematiche pene corporali che ci umiliavano profondamente.
Dovevamo sopportare un certo numero di vergate sulle mani che il maestro Pennino somministrava con un righello rosso, altrettanto vivido nella mia memoria quanto la bocca suadente della mia prima maestra. Come se tutto ciò non bastasse, pretendeva di essere pagato con un piccolo obolo – cinque o dieci lire – per consentirci di andare al bagno. Sosteneva che quello era un metodo efficace per limitare le nostre uscite durante le lezioni, ma quando mi accorsi, alla fine dell’anno, che non avrebbe devoluto l’incasso di quel balzello in qualche acquisto utile per noi scolari, bensì sigillò accuratamente il sacchetto delle monetine che aveva racimolato e se lo portò a casa, imparai con chiarezza esemplare che cosa siano i soprusi.
Tra la piccola folla dei miei professori della scuola media il primo nome che si presenta alla mia mente, in realtà, è un soprannome: Calimero. Me ne vergogno un poco, ma non ricordo il suo cognome, perché tutti noi studenti la designavamo col nome di un personaggio della pubblicità di allora: Calimero: piccolo e nero.
E lei era davvero piccola, nera di pelo, e anche brutta senza rimedio, per via di un naso imponente sul quale appoggiavano spesse lenti da miope con una pesante montatura nera. In più era alquanto umorale, per cui in certi giorni era capace persino di scherzare sul proprio aspetto sgraziato ma altre volte, invece, ci strapazzava senza pietà e, soprattutto, senza spirito.
La prof di francese, invece, si chiamava Ancarani, ed era una bella signora dal fare nobile e dal carattere assai temibile. Mangiava una gran quantità di caramelle gommose per ingannare il tempo, durante le lunghe verifiche scritte, e confesso di ricordare assai bene lo stropiccio secco delle cartine trasparenti dalle quali liberava, una dopo l’altra, le caramelle. Quello stropiccio resta nella mia memoria come una metafora della lenta e delicata fermezza con cui essa sapeva rivoltare tutti noi poveri studenti ogniqualvolta lo riteneva necessario.
Questo rito dello scartamento delle caramelle sono tornato a viverlo alle superiori. L’altrettanto temibile professor Riccardo, docente di impianti elettrici, lo celebrava con superiore distacco mentre scorreva lentamente sul proprio registro la lista degli studenti, tutti esposti ad una interrogazione, e quando la piccola golosità gommosa era stata finalmente sottratta all’impaccio della carta, egli pronunciava il nome di uno di noi. Dalle fila degli studenti, allora, qualcuno deglutiva, sebbene non avesse assolutamente nulla in bocca.
La prof di matematica si chiamava Donati, ma per tutti noi era l’Asissa, ovvero l’ascissa, cioè l’asse orizzontale del piano cartesiano. Ma lei era emiliana, e a pronunciare quel nome come si dovrebbe proprio non ci riusciva; in compenso però, possedeva una gentilezza innata così intensa e al tempo stesso così discreta, da essere quasi estranea al carattere degli emiliani, gentili ma anche sanguigni. Ci dava del lei, e penso davvero che – matematica a parte – ci considerasse proprio dei suoi pari. Ho fatto in tempo ad averla, per una volta, anche come collega: non sono riuscito a darle del tu.
Il professor Magrone, docente di elettrotecnica, non aveva alcun soprannome. Sarebbe stato superfluo appiccicargliene uno, dal momento che il suo marcato accento pugliese appagava di per sé il nostro desiderio di motteggi.
‒ Buon giorno – disse il primo giorno che entrò in classe – sono il professor Magrò-uuu-ne – avvolgendo la o del cognome con una prolungata u, come tendono a fare molti pugliesi.
Immaginammo subito che con lui ci saremmo divertiti parecchio. E in effetti ci divertimmo. Il professor Magrone era magro ‒ proprio così ‒ alto, di bell’aspetto e tanto spiritoso. Alle volte divagava, ci raccontava aneddoti vari, anche piccanti, e noi lo stavamo ad ascoltare con la massima attenzione. Però sapeva anche l’elettrotecnica, per nostra fortuna, sebbene non la prendesse mai troppo sul serio.
‒ La corrente, quella mica è scema – spiegò una volta parlando del comportamento della corrente elettrica quando attraversa due resistenze di diverso valore poste in parallelo – se ne va sempre per la strada dove fa meno fatica.
Ma il professor Magrone era anche pensatore, coltivava quella filosofia concreta ma non banale che è proprio degli ingegneri. Fu lui il primo a parteciparmi l’idea che le onde elettromagnetiche trasportano energia, e in una delle sue abituali divagazioni tecniche, aggiunse una volta:
‒ Chissà, forse un domani si potrà distribuire l’energia elettrica con le onde elettromagnetiche…
Margherita, la Delcati, il turpe Pennino, Calimero, l’Ancarani, Riccardo, l’Asissa gentile, Magrone, li ho tutti ben presenti davanti a me. Di molti altri ho taciuto, ma non per questo li ricordo con minore prontezza o ricchezza di dettagli. È la piccola folla dei miei insegnanti.
Certo, non tutti hanno lasciato un’impronta indelebile nella mia memoria. Alcuni sono transitati rapidamente dietro la cattedra, e giacciono dimenticati nell’anello crepuscolare della mia memoria, come la maggior parte degli studenti che ho incontrato. Ma molti di loro non hanno alcun bisogno di mezzi esterni, come la mia base di dati, per tornare alla ribalta, perché essi sono parte della mia esistenza.
Bisogna riconoscere che, dopo gli affetti domestici, alcuni affetti parentali e certe felici amicizie precoci, gli insegnanti sono le persone che più segnano la vita di una persona in quella fase delicata che è la formazione. Sia che si tratti di un miserabile – come è stato il maestro Pennino – sia che si tratti di una fata sapiente – come è stata la professoressa Donati – io sono in qualche misura ciò che essi, e con loro tutti quelli che hanno scritto il mio nome sul proprio Registro del Professore, mi hanno indotto a diventare.
È difficile quantificare l’entità di questa misura perché dipende da un numero talmente grande di variabili – a loro volta non quantificabili – che provarci è solo tempo perso. Ma l’importanza qualitativa dell’influenza che i docenti esercitano sull’esito della formazione di un giovane rimane un fatto senza obiezioni. Quale responsabilità, allora, ricade sulle spalle dei docenti? Io credo che ricada una responsabilità enorme.
Chi ha il compito di prendere in consegna una giovane creatura ‒ a partire dai tre anni ‒ e di frequentarla quasi quotidianamente per diversi anni, di istruirla, di incoraggiarla e di riprenderla, e ha pure il diritto di sospingerla o di fermarla sulla strada dei suoi progressi, ha una responsabilità immane, seconda solo a quella dei suoi genitori. Quando rifletto su queste cose ne sento tutto il peso, così come sento il peso della mia responsabilità di genitore.
Adesso so che nella memoria di molti degli studenti che ho incontrato, come nella memoria dei miei figli, occuperò un posto non del tutto marginale. A pensarci, la cosa mi sgomenta letteralmente. Penso al numero incalcolabile di adulti i quali – come faccio sto facendo ora – tutte le volte che si presenta l’occasione maledicono il loro antico maestro Pennino, raccontando delle sue deprecabili gesta ai figli. Però penso anche a tanti altri adulti che ricordano invece con affetto e gratitudine la soave Asissa che sapeva porgere con grazia perfino un brutto voto.
Una responsabilità immensa. Il rischio di essere dannati per una breve eternità agli occhi di un piccolo popolo. La possibilità di vivere ancora per molto tempo nel cuore di tanti. Un mestiere fuori dal comune.